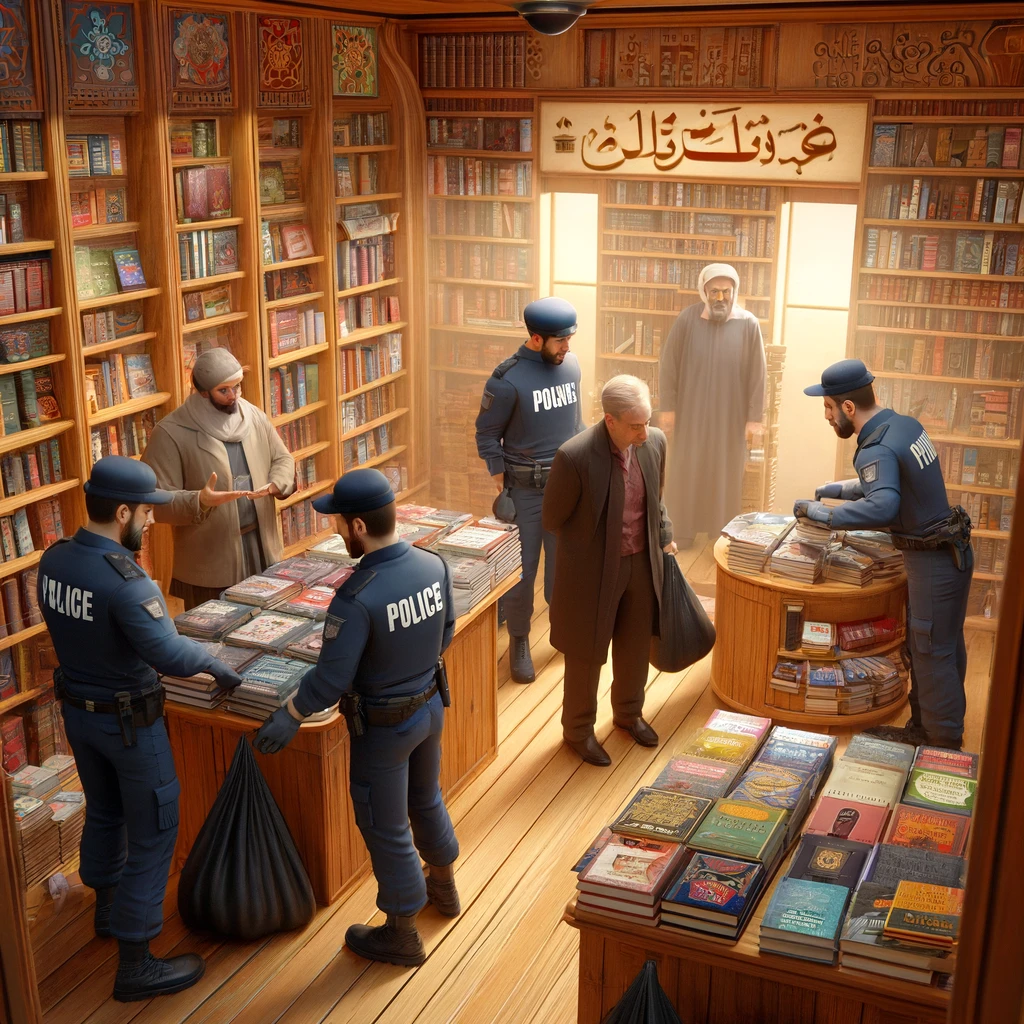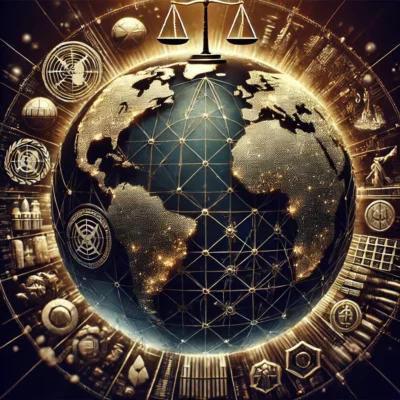Scrive Sarah Parenzo su Il Manifesto: “«Lo Stato di Israele contro Ahmad e Mahmoud Muna»: così si apre il protocollo dell’udienza tenutasi questo lunedì mattina presso il Tribunale di I grado di Gerusalemme. A difendere gli imputati dall’accusa di «turbamento dell’ordine pubblico» è l’avvocato Nasser Odeh, ma questa volta non si tratta del solito caso di palestinesi dall’identità anonima e per capirlo basta gettare un’occhiata fuori dall’aula. Nel corridoio siedono in fila rappresentanti diplomatici di Gran Bretagna, Belgio, Brasile, Francia, Svizzera, Irlanda, Svezia, Paesi Bassi e dell’Unione europea, mentre all’esterno ha luogo una manifestazione di solidarietà nella quale i dimostranti espongono cartelli con la scritta: «Non c’è santità in una città occupata». Mahmoud e Ahmad, rispettivamente zio e nipote, sono infatti a loro volta intellettuali, attivisti e imprenditori culturali, ma soprattutto gestori della celebre catena di librerie Educational bookshop, istituzione e tappa obbligata per ogni diplomatico, giornalista, attivista o ricercatore in visita a Gerusalemme est.” [1]
Michel Foucault è stato uno dei pensatori più influenti del XX secolo sul rapporto tra conoscenza e potere. Nei suoi studi, ha mostrato come il sapere non sia mai neutrale, ma sia sempre legato a sistemi di potere che lo producono e lo regolano. Il suo lavoro è fondamentale per comprendere fenomeni come la censura, il controllo dell’informazione e la costruzione della verità.
Foucault ci aiuta a vedere come il controllo della conoscenza non sia mai neutrale, ma sia sempre un’espressione del potere. Nel caso dell’Educational Bookshop, possiamo analizzare:
Il controllo del discorso (quali narrazioni sono permesse e quali no),
Il sapere come strumento di potere (chi decide cosa è “pericoloso”),
Le tecniche di disciplina e sorveglianza (autocensura e repressione),
La biopolitica e il controllo della cultura (regolazione dell’identità collettiva),
Le possibilità di resistenza (solidarietà e contro-narrazioni).
1. Archeologia del Sapere e il Ruolo dei Discorsi
Uno dei contributi fondamentali di Foucault è l’analisi dei discorsi come strutture che organizzano la conoscenza in un determinato periodo storico. Nel suo libro “L’archeologia del sapere”, Foucault mostra come la conoscenza non si sviluppi in modo lineare o progressivo, ma sia soggetta a trasformazioni determinate da regole culturali e politiche spesso invisibili.
Secondo Foucault, ogni epoca ha una propria episteme, cioè un insieme di regole che definiscono ciò che è considerato “vero” o “falso”. Queste regole non derivano solo da scoperte scientifiche o da dati oggettivi, ma sono il risultato di processi storici e sociali.
Educational Bookshop: l’accusa di diffondere “testi di istigazione al terrorismo” potrebbe essere vista come un tentativo di ridefinire i confini del discorso accettabile, stabilendo cosa può essere detto e cosa no all’interno di una specifica episteme.
2. Il Sapere come Strumento di Potere
Foucault rifiuta l’idea che il potere sia solo qualcosa che reprime e censura. Nel suo concetto di “potere-sapere”, dimostra che il potere non è solo negativo (cioè repressivo), ma anche produttivo: crea categorie, istituzioni, discipline e persino identità.
Ad esempio, nella società moderna, il sapere medico non solo descrive la malattia, ma costruisce anche la figura del “malato” come soggetto specifico. Allo stesso modo, il sapere giuridico crea la categoria del “criminale”.
Il potere è quindi diffuso ovunque e si esercita attraverso le istituzioni, le norme, il linguaggio e i discorsi.
Educational Bookshop: qui vediamo il potere operare nella costruzione del “pericolo” legato alla diffusione di determinati libri. La criminalizzazione della cultura palestinese attraverso la confisca dei testi potrebbe essere interpretata come una forma di biopolitica (vedi sotto), in cui lo Stato cerca di disciplinare e controllare la popolazione attraverso il sapere.
3. Sorveglianza e Disciplina
Nel libro “Sorvegliare e punire”, Foucault analizza l’evoluzione delle tecniche di controllo sociale, mostrando come nelle società moderne il potere non si eserciti più solo attraverso la violenza fisica, ma attraverso forme di sorveglianza e normalizzazione.
Un esempio centrale è quello del Panopticon, un modello di prigione ideato dal filosofo Jeremy Bentham, in cui i detenuti non possono vedere chi li sorveglia, ma sanno di poter essere osservati in ogni momento. Questo genera un’autodisciplina: le persone interiorizzano la sorveglianza e si comportano come se fossero sempre controllate.
Per Foucault, questo principio non riguarda solo le prigioni, ma tutte le istituzioni moderne: scuole, ospedali, fabbriche, uffici e, oggi, i media e le piattaforme digitali.
Educational Bookshop: il raid e la confisca dei libri servono non solo a eliminare determinati testi, ma anche a generare un effetto di autocensura: librai e intellettuali potrebbero evitare di trattare certi temi per paura di ritorsioni.
4. Biopolitica e il Controllo della Vita
Nel suo ultimo periodo, Foucault sviluppa il concetto di biopolitica, ovvero il modo in cui il potere moderno non si limita a governare i territori, ma disciplina direttamente la vita delle persone, regolando la salute, la riproduzione, la sessualità e persino l’accesso al sapere.
La biopolitica si manifesta attraverso leggi, istituzioni e pratiche che determinano chi ha il diritto di vivere e chi no (thanatopolitica). Ad esempio, le politiche migratorie, le pratiche di censura, il controllo delle informazioni e delle identità culturali sono tutte espressioni di biopolitica.
Educational Bookshop: il sequestro dei libri e l’arresto dei librai fanno parte di una strategia di biopolitica in cui lo Stato cerca di ridefinire non solo la narrazione storica, ma anche chi ha il diritto di raccontarla e diffonderla.
5. Resistenza e Contropoteri
Nonostante il potere sia pervasivo, Foucault non lo vede come assoluto e insormontabile. Dove c’è potere, ci sono sempre forme di resistenza. Le lotte per la libertà di espressione, le pratiche di contro-narrazione e la diffusione alternativa del sapere sono forme di resistenza al potere.
Per Foucault, non esiste un’unica “verità” da difendere, ma un campo di battaglia tra discorsi e interpretazioni. L’obiettivo non è trovare una verità assoluta, ma smascherare i meccanismi attraverso cui certe conoscenze vengono imposte come universali.
Educational Bookshop: la solidarietà internazionale, le proteste e l’acquisto di libri in risposta al raid sono forme di resistenza che rimettono in discussione il controllo del sapere imposto dallo Stato.
[1] Sarah Parenzo: <https://ilmanifesto.it/irruzione-alleducational-bookshop-libri-confiscati-e-proprietari-in-manette>